Gli attori locali
Gli attori locali, coloro che agiscono e modifican un territorio, possono dividersi in tre tipologie: gli amministratori, le imprese e i cittadini.
GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori locali hanno la responsabilità di attivare un
sistema di azioni strutturato sui tre livelli rappresentati
nella matrice per lo sviluppo locale. Essi sono condizionati,
naturalmente, da quanto accade e si evolve in ambiti
territoriali più ampi (regionale, nazionale, ecc), all’interno
dei quali il territorio dovrà competere per l’attrazione degli
investimenti, prima, e per la vendita dei prodotti/servizi e la
produzione di ricchezza, dopo.
Il primo livello riguarderà le informazioni e dovrà avere
l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli attori locali
un sapere condiviso e un linguaggio comune, che aiuta a generare
informazioni utili, assiste nelle diagnosi, nelle validazioni,
nelle valutazioni e nella implementazione dei progetti.
Il secondo livello riguarderà le decisioni e dovrà mettere in
condizione tutti gli attori interessati a partecipare al
progetto di sviluppo territoriale (soggetti responsabili), a
finalizzare le informazioni, a formalizzare i programmi di
sviluppo e i progetti di impresa.
Il terzo livello sarà operativo e dovrà mettere in condizione
tutti gli attori locali che parteciperanno al progetto di
implementare programmi e i progetti, di controllare i processi e
le azioni.
Nello schema che segue viene rappresentato il modello che
organizza il sistema di azioni che gli amministratori locali
hanno la responsabilità di attivare (Tab. 2.2).
Il punto di partenza del modello è l’analisi del contesto
territoriale, così come è condizionato dagli scenari più ampi
(regionale, nazionale, ecc), nel quale i settori produttivi
locali e gli attori sono inseriti e operano, subendo vincoli e
sfruttando opportunità (i settori), mostrando punti di forza o
di debolezza nell’agire (gli attori).
Il punto di arrivo del modello prefigura l’evoluzione temporale
degli scenari e rappresenta il contesto territoriale modificato
dalle decisioni e dalle azioni assunte ed eseguite per
valorizzare le opportunità e ridurre i vincoli di partenza dei
settori produttivi e per ridurre i punti di debolezza e
migliorare i punti di forza degli attori locali.
Il sistema delle decisioni viene raccolto in un programma di sviluppo territoriale che:
- si compone dei progetti per lo sviluppo dei sistemi produttivi;
- promuove accordi, contratti e intese di programma nei quali concorrono tutti gli attori locali interessati, ciascuno con le proprie specificità, e, eventualmente, gli attori regionali e nazionali competenti;
- individua i soggetti responsabili dell’esecuzione del programma, dei progetti e degli accordi.
Le azioni del sistema operativo sono quelle contenute nel
programma, nei progetti e negli accordi e si sostanziano, per
gli Enti Pubblici, in azioni di rimozione di ostacoli e di
creazioni di facilitazioni, in generale, e di azioni di
realizzazione di investimenti materiali (infrastrutture fisiche)
e immateriali (ricerca e formazione), nello specifico. Per le
imprese e i cittadini si sostanziano in azioni tese alla
realizzazione dei progetti di creazione e di sviluppo di imprese
previsti. Tutte le azioni degli attori dovranno essere
finalizzate alla valorizzazione delle opportunità e alla
riduzione dei vincoli misurati in partenza.
TAB. 2.2
Percorso dello sviluppo locale
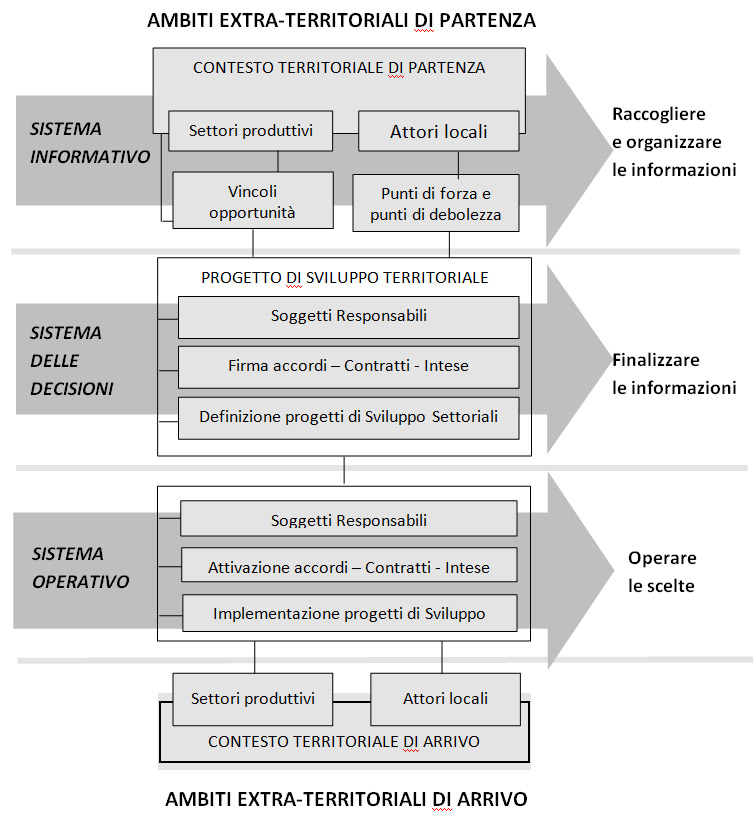 .
.
LE IMPRESE
La nascita e lo sviluppo delle imprese sono processi molto
complessi. Ancora di più quando si tratta di piccole imprese,
che possono contare, in genere, sempre su risorse umane e
finanziarie, scarse. In un progetto di sviluppo autosostenibile
è determinante supportare questi processi, per consentire agli
imprenditori locali, nuovi o esistenti che siano, di entrare in
nuovi e promettenti mercati e di competervi con successo.
Per entrare ed operare nel settore dell’energia è necessario
superare due barriere: quella tecnologica e quella finanziaria.
Se per una grande impresa è relativamente facile acquisire
tecnologia e capitali, è possibile per una piccola impresa
superare le due barriere per entrare nel mercato dell’energia ed
operarvi?
Considerato che il singolo imprenditore avrà difficoltà a fare
tutto da solo, sarà necessario costruire un sistema di rete
locale capace di generare vantaggi ed economie di scala
tecnologiche, con riferimento alle analisi delle potenzialità
(piani delle risorse con localizzazione e disponibilità), alle
forniture (facile reperibilità dei prodotti tecnologici a prezzi
bassi), alle competenze operative e imprenditoriali
(installazioni e O&M), al mercato (consegna e vendita
dell’energia).
Il sistema di rete locale permetterà ai singoli piccoli
produttori di superare i limiti tecnologici soggettivi e,
laddove ci saranno le condizioni territoriali oggettive,
ottenere la fattibilità tecnica del progetto.
La seconda barriera si supera se gli indicatori della
fattibilità economica saranno positivi e in linea con i
benchmark del settore.
Posto che le condizioni oggettive che avranno portato il
progetto di impresa alla fattibilità tecnica determinano il
miglior costo di investimento e i più convenienti costi di
gestione, le variabili che condizioneranno fortemente la
fattibilità economica saranno la producibilità stimata
dell’impianto e il prezzo di vendita complessivo dell’energia.
Si tratta, anche in questo caso, di elementi oggettivi da
combinare con i precedenti dello stesso tenore. Con una
complicazione, però, rispetto agli impianti di medie e grandi
dimensioni promossi da imprese industriali, in quanto,
trattandosi, in genere, di interventi puntiformi, la loro
fattibilità finanziaria presenta ulteriori difficoltà. Sarà,
quindi, necessario che, per rendere più facilmente finanziabile
l’impresa, venga definito un pacchetto standard di garanzie
adeguato per limitare i rischi dei finanziatori, che completi e
inglobi le condizioni tecniche ed economiche.
Un’azione di sistema si può realizzare più velocemente se gli
Enti Locali, le associazioni e gli imprenditori interessati
formalizzano la loro collaborazione, come descritto nei
paragrafi precedenti, in un accordo di programma quadro che
viene proposto agli Enti interessati e da questi sottoscritti.
I CITTADINI
I cittadini, oltre ad essere amministratori e imprenditori, sono consumatori, risparmiatori, lavoratori. In ciascuna di queste vesti, la somma dei comportamenti di ciascuno condiziona e indirizza i mercati. Anche quello dell'energia e dell'efficienza energetica.
I cittadini consumatori
Nella vita quotidiana gran parte dei consumi è abituale, legata
ad automatismi difficili da modificare. Per iniziare a
risparmiare energia elettrica (e calore) è necessario conoscere
i vantaggi, innanzitutto quelli individuali (economici) e poi
quelli collettivi (ambientali), che le scelte virtuose portano.
Si risparmia energia elettrica (e calore) non solo facendo
scelte che portano direttamente a nuovi investimenti, ma anche
attraverso comportamenti intelligenti quotidiani, che permettono
un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce
(spegnendo le luci quando non servono, non lasciando in stand by
gli apparecchi elettronici, ecc.). Con l’introduzione di
dispositivi di home automation questa tipologia volontaria di
risparmio non è più legata solo alla sensibilità dei cittadini e
ad azioni di informazione e sensibilizzazione promosse da Enti e
associazioni, ma può rientrare a pieno titolo tra le scelte
virtuose che portano a nuovi investimenti.
Investendo per migliorare l’efficienza energetica della propria
abitazione si ottiene una minore spesa in energia elettrica e
calore (risparmio energetico passivo).
Investendo per installare impianti per generare energia
elettrica o calore alimentati da fonti rinnovabili si avrà una
minore spesa (risparmio energetico attivo).
La partecipazione attiva dei cittadini ai processi di consumo
consapevole e di produzione da FER sviluppa il mercato delle
nuove e più efficienti soluzioni per risparmiare e produrre
energia.
I cittadini risparmiatori
Le risorse finanziarie locali (i risparmi dei cittadini) sono
uno dei fattori determinanti per promuovere e sostenere nel
tempo un progetto di sviluppo locale autosostenibile.
I cittadini risparmiano una quota del proprio reddito per
accantonarlo e spenderlo in un momento futuro. Il risparmio è,
di fatto, un sacrificio del consumo presente in vista di un
consumo futuro, che rende più sicuri e aumenta la sensazione di
indipendenza e di ottimismo nei confronti del domani, e consente
di programmare un investimento, che potrebbe consentire di
realizzare i propri progetti, i propri sogni, la propria vita.
Risparmiare non vuol dire solo mettere via una parte del proprio
reddito, ma anche farla fruttare scegliendo strumenti e veicoli
che, per quanto è possibile, non mettano a rischio il risparmio.
In questo contesto è fondamentale per il risparmiatore:
confrontare e conoscere le caratteristiche delle diverse offerte
degli operatori finanziari, capire che il risparmio si accresce
nel lungo termine, mai di colpo e mai per fortuna, avere sempre
il controllo dei propri soldi.
I cittadini possono affidare il proprio risparmio ad operatori
finanziari, intermediari, che assicurano loro un rendimento
(interesse) e provvedono a impiegare il denaro raccolto dai
risparmiatori verso altri cittadini e verso le imprese.
I cittadini possono, altresì, destinare il risparmio
direttamente alle imprese, sottoscrivendo obbligazioni, che
assicurano loro un rendimento (interesse), o quote sociali, che
assicurano loro un reddito (utile).
In entrambi i casi il risparmio è strettamente legato agli
investimenti. E gli investimenti sono il primo passo per la
produzione di ricchezza e per lo sviluppo economico e sociale di
un territorio. La produzione di ricchezza futura (e la
conseguente distribuzione tra i fattori produttivi che
concorrono a crearla) è resa possibile solo risparmiando
(rinunciando al consumo immediato) e impiegando il risparmio per
gli investimenti.
Per capire meglio questo concetto è utile far riferimento a
un'economia agricola, priva di contatti con i settori secondario
(industriale) e terziario (servizi, tra cui la finanza). In
questa economia agricola, senza circolazione di denaro, il
risparmio è rappresentato dall’accantonare una parte del grano
raccolto per consentire la semina per la stagione successiva. Se
tutto il raccolto fosse consumato, il ciclo produttivo non
potrebbe essere avviato nella stagione successiva: i contadini
non avrebbero cosa seminare, dissodare, raccogliere e
immagazzinare per mangiare e per risparmiare. Non si produrrebbe
nuova ricchezza da distribuire, non ci sarebbe occupazione.
Nell’economia moderna i cittadini risparmiatori promuovono gli
investimenti attraverso un intermediario professionale che
garantisce con il suo patrimonio, finanziario e di competenze
specifiche, il risparmio. Il cittadino, però, non conosce,
tranne in alcuni casi evidenziati nei paragrafi successivi, come
e dove i suoi risparmi vengono impiegati. Non sa se vengono
reinvestiti localmente o se, una volta raccolti, vengono
destinati ad altri cittadini o a imprenditori operanti in
territori diversi e distanti dal proprio. Non sa per quali
investimenti vengono impiegati. Non sa a quali tipologie di
imprese vengono affidati.
In altri casi, i cittadini risparmiatori promuovono direttamente
gli investimenti partecipando alla raccolta di capitali di
debito (le obbligazioni) e di capitali di rischio (capitale
sociale) che le imprese fanno, a loro volta, sul mercato
borsistico (le grandi imprese quotate) e localmente (le piccole
e medie imprese del territorio).
Il cittadino, in entrambe le situazioni, in forza dei prospetti
informativi di borsa e dei business plan delle imprese locali,
conosce come e dove i suoi risparmi vengono impiegati. Sa se
vengono reinvestiti localmente o se, una volta raccolti, vengono
destinati in territori diversi e distanti dal proprio, sa per
quali investimenti vengono impiegati, sa a quali tipologie di
imprese vengono affidati.
I cittadini consumatori
La nascita e lo sviluppo del mercato verde dell’energia e
dell’efficienza energetica determina, per le imprese, la
necessità di introdurre nuove tecnologie, attivare nuovi
processi, sviluppare nuove professioni.
Le esperienze maturate in altri Paesi (Germania, Danimarca e
Spagna, soprattutto) sulle possibili ricadute sulla occupazione,
in generale, e sulla composizione professionale della forza
lavoro, in particolare, indotte dallo sfruttamento su scala
industriale delle fonti energetiche rinnovabili, evidenziano, da
un lato, una enorme potenzialità di creazione di nuova
occupazione netta (si aggiunge alla esistente senza toglierla ad
altri settori concorrenti), dall’altro, una forte necessità di
sviluppo di competenze professionali specifiche.
Il cambiamento tecnologico che il risparmio energetico e
l’introduzione massiccia delle fonti energetiche rinnovabili
richiedono va letto, quindi, non solo e non tanto come un
semplice cambiamento dei meccanismi economici e produttivi, ma
anche come un radicale processo di estesa trasformazione sociale
e professionale che investe la cultura e gli stessi stili di
vita.
I progetti di sviluppo locale autosostenibile del territorio si
intrecceranno sempre più strettamente non solo con le scelte di
politica energetica, ma anche con le strategie di formazione, le
une e le altre presentandosi come due strettoie attraverso cui
necessariamente dovrà passare l’occasione di rilancio.
I ritardi che si registreranno nelle politiche formative
influenzeranno negativamente i tempi di attuazione delle
politiche energetiche ed i ritardi di entrambe potrebbero
mettere a rischio il successo di una politica finalizzata allo
sviluppo autosostenibile del territorio.
Evidenziare direttamente i fabbisogni professionali e formativi
indotti dalle nuove politiche energetiche, dar conto delle
iniziative in atto, mettere in luce i cambiamenti avvenuti o
evidenziare i ritardi e le carenze che ancora permangono sul
territorio è un modo per contribuire ad accelerare i processi di
consapevolezza collettiva e per abbattere una delle barriere che
ostacolano il successo di una politica di sviluppo
autosostenibile. È anche il modo per indirizzare parte della
domanda e, soprattutto, dell’offerta formativa, pubblica e
privata, a livello secondario superiore e soprattutto
universitario, verso un settore produttivo con ampi margini di
sviluppo.